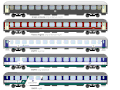railroad.wikisort.org - Tren
Le carrozze tipo UIC-X sono carrozze ferroviarie destinate al trasporto passeggeri in prevalenza su treni a media e lunga percorrenza. Alcune unità sono state convertite in tempi successivi alla consegna in versione semipilota.
|
Questa voce o sezione sull'argomento treni non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento ferrovie è ritenuta da controllare.
|
| Carrozza UIC-X | |
|---|---|
| Carrozza | |
 | |
| Anni di progettazione | 1963 |
| Anni di costruzione | 1964-1985 |
| Anni di esercizio | 1966 - oggi |
| Lunghezza | 26400 mm |
| Larghezza | 2 825 mm |
| Altezza | 4 050 mm |
| Quota del piano di calpestio | 1 223 mm |
| Interperno | 19 000 mm |
| Passo dei carrelli | 2 560 mm |
| Massa vuoto | tra 40 e 48 t, a seconda dell'allestimento e della serie |
| Velocità massima omologata | 160 km/h, 180 km/h e 200 km/h, a seconda della serie |
Le versioni costruite in Italia per le Ferrovie dello Stato, tra il 1964 e il 1985, sono il risultato di un progetto europeo che prevedeva la realizzazione di carrozze standard, uguali per tutta l'Europa, in grado di poter operare su diverse tipologie di linea. Verso la fine degli anni novanta alcune di esse sono state modificate e inserite nella categoria di trasporto regionale.
Preludio
Le carrozze UIC-X italiane derivano dallo studio della serie di carrozze tedesche tipo m prodotte in successive serie a partire dal 1954, dalle caratteristiche innovative. In particolare, queste prime unità oltre alla lunghezza elevata (pari a 26400 mm, divenuta poi uno standard) presentavano una cassa dalla struttura continua, ovvero senza le tradizionali rastremature in corrispondenza delle porte di accesso, in questo caso divise in due metà articolate del tipo Mielich. Altra innovazione era rappresentata dall'utilizzo di segmenti tubolari di gomma, semplici e di ingombro ridotto, per l'accoppiamento di due vetture adiacenti, in luogo dei pesanti e complessi mantici telati. Particolarmente moderni furono anche i carrelli del tipo Minden Deutz, dalle elevate caratteristiche dinamiche. Oltre a presentare un livello di comfort elevato anche in seconda classe, se comparato con le vetture allora in uso, si pose particolare attenzione pure alla sicurezza, con l'adozione di testate antitelescopiche per la protezione degli occupanti in caso di collisione. Tutte queste caratteristiche vennero riprese nel corso del 1961 dalla UIC nel capitolato 517, in cui si stabilivano le caratteristiche fondamentali per la costruzione di nuove vetture unificate, in modo da garantire gli stessi standard di qualità e funzionalità presso le principali amministrazioni europee.
Storia






Le UIC-X italiane furono la seconda famiglia di carrozze, circolanti stabilmente nel Paese (dopo le tipo Y), ad essere costruita secondo le logiche di standardizzazione e di interoperabilità tra i diversi sistemi ferroviari europei. Progettate nel 1963, rappresentavano un salto in avanti per quanto riguarda la qualità e le tecnologie di bordo, sia a livello di insonorizzazione, sospensioni, vetrocamere e illuminazione; potendo raggiungere facilmente una velocità massima intorno ai 140 Km/h, poi estesa su alcune serie entro i 160/180 Km/h, fino ai 200 km/h nell'ambito dei servizi rapidi.[1] Dal punto di vista strutturale le varie parti del telaio della cassa, realizzate in sottomoduli (imperiale, fiancate), le rendevano più economiche da produrre e più semplici da assemblare; ulteriori elementi migliorativi vennero poi attuati dalle industrie private durante le successive fasi di consegna.
Come per la gran parte delle precedenti carrozze già in dotazione al parco FS anche le UIC-X furono prodotte in diversi allestimenti e con una diversa configurazione dei finestrini e delle fiancate a seconda della classe. Quelle del servizio ordinario, dotate di scompartimenti con posti a sedere reclinabili, nella versione di prima classe potevano ospitare fino a 60 passeggeri distribuiti in 10 scompartimenti, mentre nella seconda classe gli scompartimenti salivano a 12, per un totale di 72 posti più 15 strapuntini. Alcuni esemplari furono inoltre allestiti in versione mista, con 30 posti di prima classe e 36 di seconda. Le ordinarie risultarono peraltro la prima tipologia di carrozza dotata di 3 posti affiancati per scompartimento anche in seconda classe, a differenza dei 4 presenti nelle serie precedenti "Tipo 1959" e nelle serie UIC-X di alcune compagnie estere. Accanto alle ordinarie vennero poi ordinate nel tempo un certo numero di unità in allestimento cuccette, da impiegare in composizione ai convogli notturni inseriti come da quadro orario nelle relazioni Nord-Sud del Paese, quali ad esempio la Freccia del Sud, ed i gradi espressi internazionali. Proprio nell'ottica di arricchire l'offerta di questi treni, fra gli anni sessanta e i primi anni settanta, le Ferrovie dello Stato decisero di far realizzare alcune UIC-X nella tipologia "ristoro"; in realtà non erano delle vere e proprie carrozze ristorante ma disponevano comunque a bordo di una cucina, un po' sul modello delle Buffet-Bar tedesche.[2] Completarono la fornitura alcuni esemplari specificatamente adibiti al trasporto bagagli (bagagliai), ai servizi postali (postali), al trasporto detenuti (cellulari).[3]
Fino ai primi anni ottanta la quasi totalità delle carrozze, escluse rare eccezioni, rivestì la livrea grigio ardesia con alcune differenze a livello di marcature grafiche (in funzione dei compiti ai quali erano assegnate) e delle porte, verniciate o non verniciate, in principio imputabile a seconda del lotto di fornitura (per esempio, dalle Tipo 1970 furono adottate porte in alluminio anodizzato colore oro chiaro e in alcuni casi in colore argento, mentre per le serie precedenti erano in acciaio verniciato in tinta con la carrozzeria, salvo poi essere in alcuni casi sostituite in favore di quelle in alluminio anodizzato in fase di revisione).[4] Le vetture ammesse a circolare entro una velocità massima di 200 Km/h vennero identificate mediante l'applicazione di una fascia rossa orizzontale a livello della parte inferiore della cassa, trovando largo impiego al traino delle locomotive elettriche E.444, soprattutto sulla linea direttissima Firenze-Roma.[5]
Sin dai primi anni di esercizio le UIC-X subirono vari interventi di migliorie e aggiornamenti, in particolare in riferimento agli impianti di climatizzazione e riscaldamento degli scompartimenti. Alcune unità uscirono oltretutto dagli impianti montando carrelli di fabbricazione Fiat in luogo dei classici tipo Minden Deutz. Durante la consegna negli anni ottanta dell'ultima fornitura di vetture denominata Tipo 1982, queste ultime in corso d'opera adottarono il tetto cannellato a differenza delle prime che ebbero il tetto liscio. Fu proprio con le Tipo 1982 che debuttò, dopo alcuni esperimenti caduti nel vuoto, la nuova livrea rosso fegato, ben presto estesa alla gran parte delle unità del gruppo.[6] Verso la fine del decennio, in concomitanza al declino delle attività nell'ambito dei servizi postali e dedicati al trasporto bagagli molte carrozze adibite a tale scopo furono progressivamente accantonate e in alcuni casi trasferite in tempi successivi ad altro impiego, come nel caso dell'utilizzo in composizione a convogli diagnostici (esempio, il Treno Misure Archimede) o per il trasporto delle biciclette; mentre un modesto quantitativo di esemplari esonerato dall'asset passeggeri finì reimpiegato nel ruolo di vetture scudo.
A causa della riorganizzazione dei servizi internazionali e dello sviluppo delle prime linee ad alta velocità, tra gli anni novanta e gli anni duemila, molte carrozze ancora in esercizio vennero dirottate presso le varie DTR regionali, così da integrare convogli composti da materiale eterogeneo MDVC/MDVE, o più semplicemente per dare vita a nuovi complessi omogenei, in grado di ovviare all'acquisto di nuovo materiale rotabile; il più delle volte variando elementi della livrea se non l'intera colorazione dal rosso fegato allo schema XMPR, questo per gli esemplari che non sarebbero stati nel breve termine accantonati, o nel caso, ceduti ad altre compagnie, tra le quali le Ferrovie Albanesi. Proprio nell'ottica di allungare la vita alle UIC-X, sul finire degli anni novanta, le FS (poi Trenitalia) vararono un piano di revamping completo o parziale della flotta residua, destinata a svolgere i treni a lunga percorrenza (ordinarie e cuccette) e regionali. Alcune di esse videro la sostituzione delle porte manuali con porte automatiche, la rimozione degli scalini esterni delle porte, la ristrutturazione completa degli ambienti interni, l'adozione di nuovi finestrini, la trasformazione di alcune vetture in semipilota (nell'ambito dei treni regionali) utilizzando analoghe forme delle cabine già viste con la trasformazione delle locomotive E.444 in E.444R e ridisegnando gli scompartimenti (a tale scopo venne ribassata la parte centrale della carrozza aggiungendo uno scompartimento per i disabili e un bagno. Inoltre, in uno spazio lasciato all'altezza originale, tra la cabina e le porte ribassate, venne adibita una piccola zona per le biciclette). Non di rado le semipilota adibite al servizio regionale vengono ancora usate in composizione con carrozze eterogenee, segnatamente. Dagli anni duemiladieci le UIC-X sono le carrozze principali per l'espletamento dei servizi InterCity Notte, tuttavia alcune di queste continuano ad essere impiegate, seppur in misura ridotta, al traino dei treni regionali.[7] Fra il 2011 e il 2021 un cospicuo numero di esemplari fu utilizzato alla società Thello.
Nel 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, alcune carrozze UIC-X dismesse dai servizi viaggiatori a lunga percorrenza sono state modificate e convertite in carrozze ospedale ex "barellate" per espletare attività legate al trasporto di degenti e materiale sanitario. Molte di queste sono state dotate di letti e su tutte sono stati oscurati i finestrini con pannelli bianchi. Per distinguerle da quelle adibite ai servizi viaggiatori rivestono un'inedita livrea bianca, simile a quella nuova degli InterCity Giorno, ma con l'aggiunta di strisce rosse e verdi sulle fiancate per simboleggiare i colori della bandiera italiana, con il simbolo internazionale di soccorso su entrambe le fiancate a lato delle porte (dal 2022 gli elementi grafici in riferimento alla bandiera italiana risultano rimossi). Questa piccola flotta, allestita nelle officine Trenitalia di Voghera, grazie al contributo di Ferrovie dello Stato, Protezione civile e Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) rimarrà a disposizione anche superata la pandemia, per scopi emergenziali ed umanitari, essendo equipaggiate di strumentazioni mediche di pronto soccorso.[8] Già in passato, alcune UIC-X furono concepite fin dall'origine nella cosiddetta versione "barellate" (si tratta delle 10 UIC-X 1978 consegnate alle FS nel 1981) per il trasporto dei malati in occasione dei pellegrinaggi mariani. All'atto della loro entrata in servizio queste unità adottavano lo schema di coloritura in bianco ghiaccio con fasce in tre tonalità di azzurro e croce rosso segnale ad una di entrambe le estremità delle fiancate. Disponevano a bordo di 36 barelle, mentre il riscaldamento era inizialmente garantito da apparecchiature ad aria soffiata Westinghouse, sostituite nel corso degli anni novanta da un più moderno impianto di climatizzazione.[9] Nel tempo, altre UIC-X ricondizionate sono state adattate accanto alle ex "barellate" per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria, nell'ambito del progetto Treni Bianchi dell'Unitalsi, diretti principalmente a Lourdes. Dagli anni duemila tale materiale ha rivestito lo schema di coloritura in livrea XMPR, ma dopo l'avvio nel 2019 delle attività connesse a un progetto di ristrutturazione dello stesso Trenitalia ha deciso di dotarlo di una livrea specifica, simile a quella nuova degli InterCity Notte, con grandi fasce blu al cui interno sono racchiusi elementi decorativi in grigio, bianco e oro, oltre alle porte in rosso. Le prime carrozze sono state riqualificate presso le officine IMC di Reggio Calabria che hanno assunto l'incarico di effettuare la manutenzione dei convogli dei pellegrini.[10]
Nel 2021, la quota residua di UIC-X destinate al servizio regionale ha iniziato a rivestire la nuova livrea DPR di Trenitalia, mediante lo schema di coloritura del tutto analogo a quello in corso di applicazione sulle carrozze MDVC/MDVE; la prima unità a riceverla è stata la semipilota 50 83 80-87 602-1 I-TI del compartimento Calabria.[11] Al momento la nuova livrea DPR viene applicata alle sole vetture pilota essendo le unità intermedie destinate all'accantonamento.
Galleria d'immagini
- Riproduzione Fleischmann in scala N di una carrozza UIC-X, in Livrea Grigio Ardesia.
- Riproduzione A.C.M.E. in scala H0 di una carrozza tipo UIC-X a cuccette (95R, T4), in livrea XMPR (Treno Notte), destinata agli InterCity Notte.
- Riproduzione A.C.M.E. in scala H0 di due carrozze tipo UIC-X (revisione "Giubileo"), in livrea XMPR PAX, destinate agli InterCity Notturni e Diurni.
- Veduta di alcuni scompartimenti di una carrozza tipo UIC-X (revisione "Giubileo"), in livrea XMPR PAX, scala H0.
- Riproduzione A.C.M.E. in scala H0 di una carrozza tipo UIC-X (revisione "Giubileo"), in livrea XMPR (ICN), destinata agli InterCity Notte.
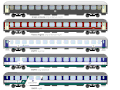 Le livree utilizzate per le carrozze UIC-X (grigio ardesia; grigio-beige-rosso fegato; XMPR (a partire dal 2000); XMPR Giubileo (a partire dal 2000); livrea XMPR "Treno Notte".
Le livree utilizzate per le carrozze UIC-X (grigio ardesia; grigio-beige-rosso fegato; XMPR (a partire dal 2000); XMPR Giubileo (a partire dal 2000); livrea XMPR "Treno Notte". La livrea Artesia in utilizzo fino all' anno 2010, circa.
La livrea Artesia in utilizzo fino all' anno 2010, circa.- Alcune carrozze UIC-X, in Livrea Grigio Ardesia, e con le porte a battente.
- Alcune Carrozza UIC-X, in livrea Grigio-Beige-Rosso Fegato, e con le porte a battente.
- Una carrozza UIC-X a cuccette, per InterCity notte, revampizzata (T4), con le porte a battente e in livrea XMPR.
- Una Carrozza UIC-X per gli Intercity Notte, in livrea Artesia, revampizzata, ma con le porte a battente.
- Una carrozza UIC-X "Giubileo", per gli InterCity notturni e diurni, non revampizzata, in livrea XMPR PAX, con i finestrini originali e le porte a battente.
- Una carrozza UIC-X per i Treni Regionali, in livrea XMPR, non revampizzata, con i finestrini originali e le porte a battente.
- Due carrozze UIC-X Semipilota in livrea XMPR, alla stazione di Torino Porta Nuova.
- L'interno di una carrozza UIC-X trasformato a salone per il servizio regionale, 31 Maggio 2011.
Note
- Carrozze UIC-X – parte prima: introduzione, le origini e le carrozze estere, Scalaenne, 4 giugno 2011.
- Carrozze UIC-X – parte quinta: le carrozze ristoro, Scalaenne, 16 marzo 2013.
- Carrozze UIC-X parte settima: postali e bagagliai, Scalaenne, 20 luglio 2013.
- Carrozze UIC-X – parte terza: le sei serie italiane, Scalaenne, 19 gennaio 2013.
- Buon compleanno Tartaruga, Tutto treno Blog, 8 novembre 2017.
- Carrozze UIC-X – parte seconda: tipologie e livree italiane, Scalaenne, 5 gennaio 2013.
- Carrozze UIC-X parte quarta: l’epoca XMPR e il revamping, Scalaenne, 9 febbraio 2013.
- Ferrovie: pronto il Treno Sanitario di Ferrovie dello Stato, Protezione Civile e Areu, Ferrovie.info, 22 maggio 2020.
- Le carrozze per malati Tipo UIC-X 1978, Ferrovie.info, 16 maggio 2017.
- Nuova livrea per il parco vetture utilizzato dall'Unitalsi per i pellegrinaggi mariani, ReggioToday, 24 giugno 2019.
- Nuova livrea per le UIC-X Revamping, Ferrovie.it, 24 marzo 2021.
Bibliografia
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Relazione annuale – 1974, 1975.
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Relazione annuale – 1977, 1978.
- Angelo Nascimbene, Le carrozze X, in Italmodel Ferrovie, giugno 1979, pp. 30-37.
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Relazione annuale – 1981, 1982.
- Michele Mingari, Carrozze tipo X per viaggiare comodi, in I Treni Oggi, n. 105, giugno 1990.
Voci correlate
- Carrozza UIC-Y
- Carrozza UIC-Z
- Carrozza UIC-Z1
- Carrozze FFS tipo RIC
Altri progetti
 Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carrozza UIC-X
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carrozza UIC-X
Collegamenti esterni
- Galleria fotografica, su amicitreni.net (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2007).
- Tipologie e livree vetture delle vetture UIC-X italiane, su scalaenne.wordpress.com.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии